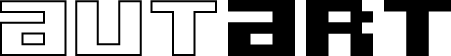Si può affermare senza paura di sbagliare che in Italia l’artista, dopo i poliziotti e i preti, è l’essere più comunemente disprezzato. Le ragioni per cui è disprezzato sono spesso false ragioni, frutto dell’ideologia dominante, ma le ragioni per cui è effettivamente disprezzabile dal punto di vista della critica politica andrebbero dichiarate apertamente.
Sono diverse le definizioni a cui questo soggetto può essere associato. Nei luoghi in cui la produzione è ancora percepita come strettamente legata alle ore di lavoro prestato per salario l’artista è comunemente considerato inutile ai processi produttivi. Una tale concezione dell’economia, però, può considerarsi molto lontana dal reale. In altri luoghi in cui l’artista è considerato esperto di una particolare tecnica, esso viene associato all’artigiano che produce oggetti d’arte. Niente di più illusorio e forviante. Probabilmente la peggiore e la più ideologica delle sue definizioni è quella legata ad un’idea di arte come territorio dell’esperienza estetica pura in cui l’artista è portatore di una verità altra inaccessibile ai più. Tutte definizioni che nascondono la sua realtà, cioè essere parte attiva, suo malgrado, di un processo economico che si riproduce.
Il mercato dell’arte è una delle espressioni forse più alte di mercato finanziario. Esso si basa su di un sistema di opinioni che definiscono le quotazioni degli oggetti venduti, al di là della natura dell’oggetto. Il valore delle quotazioni è garantito dalla presenza di una innumerevole quantità di giovani artisti che prestano lavoro non solo precario ma addirittura gratuito nella speranza di raggiungere un traguardo inesistente. Questi giovani artisti si sentono tanto più liberi e realizzati quanto più si incatenano a questo tipo di meccanismo. Da studenti analizzano come le diverse produzioni vengono esposte, come vengono comunicate e criticate. Studiano gli stili e le tendenze, le inclinazioni e gli incidenti. Le opere così diventano l’espressione più alta di come il pensiero possa essere trasformato in economia. Ogni oggetto, video, tela, installazione è una trovata, un pretesto, un elemento utile alla sopravvivenza di questo mercato.
La situazione non è cambia neanche quando nel ’99 il processo di Bologna a visto le Accademie travolte dall’idea di riforma a costo zero. Il piani didattici sono stati trasformati per introdurre materie che possano consentire un più agevole inserimento nel mondo del lavoro facendo strada al sistema del 3+2. Le tasse scolastiche sono state aumentate a dismisura pesando sugli studenti, così sempre più poveri e pronti a diventare i precari della conoscenza di domani. I legami con i sistemi di produzione economica si sono fatti più stretti ma sono stati attenuati dall’idea di una possibilità lavorativa più concreta. Ciò che viene insegnato è pensato per essere utile a questo sistema economico sia che si tratti di analisi teoriche sia che si tratti di realizzazioni pratiche: comunicazione, grafica, design, fashion, programmazione. Ma come si può anche solo pensare di essere parte di un sistema economico che non funziona più? Come ci si può cullare su di un illusorio inquadramento nel mondo del lavoro schiavi di un processo ormai alla fine?
Ci è sembrato indispensabile avviare anche all’interno delle Accademie zone di autonomia didattica in cui gli studenti avessero il tempo di rielaborare la propria formazione e le proprie intenzioni. Abbiamo pensato ad un’autoformazione che prendesse in considerazione sia l’aspetto teorico che quello pratico e attraverso quest’ultimo potesse essere un’occasione per valorizzare possibili relazioni tra soggettività diverse.
Ma in questo scenario c’è da prendere meglio in considerazione cosa ha significato per le Accademie il processo di Bologna. Quel vertice ha visto la stesura della legge 21 dicembre 1999, n. 508 che prevedeva la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Le disposizioni in essa contenute erano norme di principio, la cui attuazione era rimessa ad uno più regolamenti, da adottarsi da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università entro e non oltre il 31 Dicembre del 2007. Parte di questi regolamenti sono stati stilati e firmati in fretta e furia il 27 dicembre del 2007 quando da mesi le Accademie avevano avviato una mobilitazione nazionale contro molti punti di questa legge. L’attuazione è stata parziale e assolutamente confusionaria gettando gli studenti in un limbo istituzionale che continua ancora adesso. In questa situazione per noi è stato possibile intervenire all’interno della didattica ottenendo un riconoscimento delle attività svolte. Tuttavia ci sembra insufficiente che questo successo possa dipendere solo da un assenza legislativa. Il diritto di decisione nella didattica per gli studenti deve essere riconosciuto nei decreti attuativi sin nelle stanze del Ministero.
Allo stato attuale il valore legale del nostro titolo di studio è parziale e poco chiaro. Questo ci lascia in balia del mercato lavorativo senza avere alcun diritto. In più dal punto di vista amministrativo le Accademie non sono entrate a far parte dei circuiti universitari e per questo gli studenti non possono godere degli stessi diritti. Quindi nessuna borsa di ricerca o dottorato ci spetta. I doplomandi accademici subiranno un criterio di selezione lavorativa basato sul prestigio dell’istituzione da cui provengono in cui gli interventi dei privati sono stati ormai ampiamente legittimati. Questo avveniva prima che la crisi fosse una realtà tangibile per tutti. Si prepavano le basi per creare all’interno delle Accademie schiavi senza diritti. Con maggiore consapevolezza di quello che ci aspetta incominciamo a difenderci protestando contro il vertice che si terrà a Torino. Un vertice del tutto simile a quello che ci ha portato in questa condizione. Dobbiamo essere noi a scegliere e rifiutare di non avere possibilità di scelta. Vogliamo il diritto ad un valore legale del nostro titolo di studio pur conservando la nostra specificità di saperi. Vogliamo che gli studenti siano parte attiva nella decisione didattica. Vogliamo la possibilità di una ricerca libera.